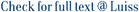“Se ami Barbie questo film è per te. Se odi Barbie questo film è per te”. Il trailer del fenomenale successo commerciale di un film destinato a infrangere un numero significativo di record al punto tale da generare un neologismo come “Barbiellion” (Barbie+Billion), ostenta in modo inequivocabile una caratteristica distintiva dei brand di successo più longevi, la capacità di agire come una forma di mitologia contemporanea intercettando, traducendo e amplificando visioni del mondo diverse, finanche contrapposte, con l’ambizione di proporne una sintesi (inevitabilmente ideologica) che infrange la distinzione tra prodotto culturale e prodotto di consumo. Come nel caso del valore/disvalore cardine della società occidentale, la bellezza, con tutto il conflitto interpretativo che ne caratterizza il senso. Perfezione/imperfezione, esclusione/inclusione, artificiale/naturale, stereotipato/autentico... Barbie, al di là del dibattito sul valore estetico della pellicola si rivela così un’operazione di marketing al tempo stesso sofistica- ta e sfacciata, un’azione di rebranding che celebra, svelandone i paradossi, l’unicità di un prodotto dalle caratteristiche uniche, tanto celebre da indur- re a utilizzare un nome proprio per riferirsi comunemente non solo a un idealtipo umano ma a un’intera categoria di prodotto: a significare la bam- bola per antonomasia. Mattel, dopo un travagliato processo di produzione, la cui durata (quattordici anni) segnala la difficoltà nel gestire eredità e potenziale di un prodotto di massa tanto longevo quanto discusso, entra così a pieno titolo nell’era del brand activism, in cui dalle marche ci si aspetta una prova di maturità che consiste nella capacità di offrire risposte credibili all’opinione pubblica, di prendere posizione, di scegliere da che parte stare all’interno di una tensione che è al tempo stesso politica, economica, sociale, culturale. Ovvio, si potrebbe obiettare. Eppure, a ben guardare, lo scenario del brand activism è la risultanza di un processo evolutivo incentrato su un principio tutt’altro che scontato e che tuttavia per lungo tempo non è stato comunemente accolto, quello secondo cui il valore economico di un brand è il risultato e non la causa del suo capitale simbolico, vale a dire della capacità di acquisire, rappresentare e rinegoziare un senso, declinando un insieme di valori sotto forma di racconti. Ora, gestire un simbolo è questione tutt’altro che elementare, come emerge chiaramente se si prova a rispondere a una domanda apparentemente banale: a chi appartiene? Certo il copyright è questione quanto mai determinante, ma sarebbe davvero riduttivo limitare la portata della domanda alla dimensione giuridica e commerciale del fenomeno, dal momento che, come ricorda Umberto Eco, ciò che contraddistingue i simboli è la capacità di coinvolgere una molteplicità di attori portatori di prospettive interpretative spesso in aperto conflitto tra di loro al punto che se da un lato non c’è accordo su ciò che il simbolo vuole dire (e Barbie lo dimostra), dall’altro si è d’accordo nel riconoscergli un potere semiotico, vale a dire la capacità di acquisire una molteplicità di significati e di esprimere un’efficacia sul piano pragmatico, vale a dire di generare una molteplicità di reazioni. Insomma, la vitalità di un simbolo si misura sulla lunga durata e il suo senso va indagato nella dialettica delle interpretazioni e degli usi che da esso e intorno a esso prendono forma. Questo piccolo preambolo ci aiuta a inquadrare la decisione di proporre per la prima volta in lingua italiana la traduzione di un celebre lavoro di Douglas Holt, pioniere del cultural branding: il libro How brands become icons, pubblicato nel lontano 2004 e che a distanza di diciannove anni si può considerare un classico, per due ordini di ragioni. In primo luogo, si tratta di un lavoro attuale perché aiuta a comprendere come l’efficacia di un brand, la sua autorevolezza non possa essere colta se non esaminando la dimensione politica e culturale con la quale si misura e che, a sua volta, contribuisce a plasmare, divenendo a tutti gli effetti un attore sociale. In secondo luogo, si tratta di un libro pionieristico e al contempo provocatorio che mira a mettere fortemente in discussione gli assiomi sui quali si fondano i principali modelli imperanti negli studi di marketing, illustrando, con l’ausilio di un corpus di casi esemplari, come le teorie e le metodologie dominanti nelle business school non siano in grado di rendere conto del successo e della tenuta nel tempo di brand iconici come Coca-Cola, a causa di un pregiudizio ancora oggi radicato che consiste nel sottovalutare l’apporto di discipline volte all’analisi della cultura di massa come l’antropologia, la sociologia, le scienze della comunicazione, i film studies, la storia contemporanea. Gli uomini di marketing, ci rammenta Holt, spesso concepiscono i brand come fenomeni psicologici che rinviano alle percezioni del singolo consumatore, ma ciò che rende realmente influente una marca non può che essere la natura collettiva dei giudizi e delle sensazioni che essa rappresenta e a cui fornisce una consistenza materiale, la capacità di trascendere la dimensione soggettiva dell’interpretazione per investire il piano ben più ampio dell’identificazione collettiva in una serie di valori esistenziali. Insomma, occorre riconoscere l’urgenza di guardare oltre l’individuo, spingendosi piuttosto a esplorare il ruolo sociale delle marche, la funzione di orientamento che sono in grado di assumere nell’opinione pubblica. E i mezzi che consentono di raggiungere questo traguardo, decisamente ambito perché può assicurare a un brand un vantaggio difficilmente intaccabile dai suoi competitor, sono tutt’altro che facili da riconoscere e, ancora meno, da maneggiare. Si tratta della dimensione simbolica e di quella narrativa che la combinazione di linguaggi differenti (verbale, visivo, musicale, audiovisivo) dispiega. Se il senso di un brand iconico non può che risiedere e risuonare nelle storie che costruisce, modifica, adatta, fa circolare, ecco così prendere forma la scommessa di questo libro secondo cui nessuna narrazione efficace è possibile senza la capacità di esprimere una rigorosa critica culturale, una presa di posizione teorica che nell’ambito degli studi sul consumo è al fondamento della consumer culture theory (Cct) nel cui sviluppo, il lavoro di Holt ha svolto, non a caso, un ruolo decisivo.
Peverini, Paolo. (2023). Prefazione: Miti del consumo/consumo dei miti. In Paolo Peverini; Dario Mangano (Eds.), Cultural Branding: Come i brand diventano icone. (pp. 9-17). LUISS University Press. Isbn: 9788861057920.
Prefazione: Miti del consumo/consumo dei miti
Paolo Peverini
2023
Abstract
“Se ami Barbie questo film è per te. Se odi Barbie questo film è per te”. Il trailer del fenomenale successo commerciale di un film destinato a infrangere un numero significativo di record al punto tale da generare un neologismo come “Barbiellion” (Barbie+Billion), ostenta in modo inequivocabile una caratteristica distintiva dei brand di successo più longevi, la capacità di agire come una forma di mitologia contemporanea intercettando, traducendo e amplificando visioni del mondo diverse, finanche contrapposte, con l’ambizione di proporne una sintesi (inevitabilmente ideologica) che infrange la distinzione tra prodotto culturale e prodotto di consumo. Come nel caso del valore/disvalore cardine della società occidentale, la bellezza, con tutto il conflitto interpretativo che ne caratterizza il senso. Perfezione/imperfezione, esclusione/inclusione, artificiale/naturale, stereotipato/autentico... Barbie, al di là del dibattito sul valore estetico della pellicola si rivela così un’operazione di marketing al tempo stesso sofistica- ta e sfacciata, un’azione di rebranding che celebra, svelandone i paradossi, l’unicità di un prodotto dalle caratteristiche uniche, tanto celebre da indur- re a utilizzare un nome proprio per riferirsi comunemente non solo a un idealtipo umano ma a un’intera categoria di prodotto: a significare la bam- bola per antonomasia. Mattel, dopo un travagliato processo di produzione, la cui durata (quattordici anni) segnala la difficoltà nel gestire eredità e potenziale di un prodotto di massa tanto longevo quanto discusso, entra così a pieno titolo nell’era del brand activism, in cui dalle marche ci si aspetta una prova di maturità che consiste nella capacità di offrire risposte credibili all’opinione pubblica, di prendere posizione, di scegliere da che parte stare all’interno di una tensione che è al tempo stesso politica, economica, sociale, culturale. Ovvio, si potrebbe obiettare. Eppure, a ben guardare, lo scenario del brand activism è la risultanza di un processo evolutivo incentrato su un principio tutt’altro che scontato e che tuttavia per lungo tempo non è stato comunemente accolto, quello secondo cui il valore economico di un brand è il risultato e non la causa del suo capitale simbolico, vale a dire della capacità di acquisire, rappresentare e rinegoziare un senso, declinando un insieme di valori sotto forma di racconti. Ora, gestire un simbolo è questione tutt’altro che elementare, come emerge chiaramente se si prova a rispondere a una domanda apparentemente banale: a chi appartiene? Certo il copyright è questione quanto mai determinante, ma sarebbe davvero riduttivo limitare la portata della domanda alla dimensione giuridica e commerciale del fenomeno, dal momento che, come ricorda Umberto Eco, ciò che contraddistingue i simboli è la capacità di coinvolgere una molteplicità di attori portatori di prospettive interpretative spesso in aperto conflitto tra di loro al punto che se da un lato non c’è accordo su ciò che il simbolo vuole dire (e Barbie lo dimostra), dall’altro si è d’accordo nel riconoscergli un potere semiotico, vale a dire la capacità di acquisire una molteplicità di significati e di esprimere un’efficacia sul piano pragmatico, vale a dire di generare una molteplicità di reazioni. Insomma, la vitalità di un simbolo si misura sulla lunga durata e il suo senso va indagato nella dialettica delle interpretazioni e degli usi che da esso e intorno a esso prendono forma. Questo piccolo preambolo ci aiuta a inquadrare la decisione di proporre per la prima volta in lingua italiana la traduzione di un celebre lavoro di Douglas Holt, pioniere del cultural branding: il libro How brands become icons, pubblicato nel lontano 2004 e che a distanza di diciannove anni si può considerare un classico, per due ordini di ragioni. In primo luogo, si tratta di un lavoro attuale perché aiuta a comprendere come l’efficacia di un brand, la sua autorevolezza non possa essere colta se non esaminando la dimensione politica e culturale con la quale si misura e che, a sua volta, contribuisce a plasmare, divenendo a tutti gli effetti un attore sociale. In secondo luogo, si tratta di un libro pionieristico e al contempo provocatorio che mira a mettere fortemente in discussione gli assiomi sui quali si fondano i principali modelli imperanti negli studi di marketing, illustrando, con l’ausilio di un corpus di casi esemplari, come le teorie e le metodologie dominanti nelle business school non siano in grado di rendere conto del successo e della tenuta nel tempo di brand iconici come Coca-Cola, a causa di un pregiudizio ancora oggi radicato che consiste nel sottovalutare l’apporto di discipline volte all’analisi della cultura di massa come l’antropologia, la sociologia, le scienze della comunicazione, i film studies, la storia contemporanea. Gli uomini di marketing, ci rammenta Holt, spesso concepiscono i brand come fenomeni psicologici che rinviano alle percezioni del singolo consumatore, ma ciò che rende realmente influente una marca non può che essere la natura collettiva dei giudizi e delle sensazioni che essa rappresenta e a cui fornisce una consistenza materiale, la capacità di trascendere la dimensione soggettiva dell’interpretazione per investire il piano ben più ampio dell’identificazione collettiva in una serie di valori esistenziali. Insomma, occorre riconoscere l’urgenza di guardare oltre l’individuo, spingendosi piuttosto a esplorare il ruolo sociale delle marche, la funzione di orientamento che sono in grado di assumere nell’opinione pubblica. E i mezzi che consentono di raggiungere questo traguardo, decisamente ambito perché può assicurare a un brand un vantaggio difficilmente intaccabile dai suoi competitor, sono tutt’altro che facili da riconoscere e, ancora meno, da maneggiare. Si tratta della dimensione simbolica e di quella narrativa che la combinazione di linguaggi differenti (verbale, visivo, musicale, audiovisivo) dispiega. Se il senso di un brand iconico non può che risiedere e risuonare nelle storie che costruisce, modifica, adatta, fa circolare, ecco così prendere forma la scommessa di questo libro secondo cui nessuna narrazione efficace è possibile senza la capacità di esprimere una rigorosa critica culturale, una presa di posizione teorica che nell’ambito degli studi sul consumo è al fondamento della consumer culture theory (Cct) nel cui sviluppo, il lavoro di Holt ha svolto, non a caso, un ruolo decisivo.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Cultural Branding versione stampa.pdf
Solo gestori archivio
Tipologia:
Versione dell'editore
Licenza:
Tutti i diritti riservati
Dimensione
2.65 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.65 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.