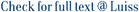La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, nel caso passato agli onori delle cronache come “Google Spain”, è da mesi al centro di un serrato dibattito mondiale che non riguarda solo il problema della tutela dei diritti della personalità in Internet (in specie, privacy ed oblio), ma coinvolge questioni ancora più fondamentali (perché di impatto generale) che vanno dal controllo sui contenuti della grande Rete ai limiti alla libertà di informazione on-line. Sennonché, le conclusioni a cui perviene la citata sentenza non risultano convincenti laddove si impone ai motori di ricerca di deindicizzare (e cioè non considerare nell’ambito delle ricerche avviate dagli utenti) i contenuti considerati lesivi del diritto all’oblio degli interessati; ed infatti, non a caso, esse appaiono in contrasto con la giurisprudenza sul punto della Cassazione italiana e della CEDU. Il rischio maggiore di una tale soluzione, a prescindere dalla sua sostanziale inefficacia pratica dovuta al fatto che il principio vincola gli operatori solo all’interno dei confini europei, consiste nell’attribuire a soggetti privati – quali sono, per l’appunto, i provider che esercitano i motori di ricerca – il potere di decidere quali contenuti della Rete rendere rintracciabili agli utenti e quali invece sostanzialmente nascondere, o meglio nel legittimare, sul piano giuridico, l’esercizio, più o meno arbitrario, di un potere che, di fatto, detti provider hanno già. Sullo sfondo, e tutto intorno, la profonda crisi del diritto rispetto alle nuove tecnologie.
Di Ciommo, Francesco. (2014). Quello che il diritto non dice. Brevi note (ancora) su Internet e oblio alla luce del caso "Google Spain" ed altri recenti (contraddittori) arresti pretori.. DANNO E RESPONSABILITÀ, (ISSN: 1125-8918),12, 1101-1113.
Quello che il diritto non dice. Brevi note (ancora) su Internet e oblio alla luce del caso "Google Spain" ed altri recenti (contraddittori) arresti pretori.
DI CIOMMO, FRANCESCO
2014
Abstract
La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, nel caso passato agli onori delle cronache come “Google Spain”, è da mesi al centro di un serrato dibattito mondiale che non riguarda solo il problema della tutela dei diritti della personalità in Internet (in specie, privacy ed oblio), ma coinvolge questioni ancora più fondamentali (perché di impatto generale) che vanno dal controllo sui contenuti della grande Rete ai limiti alla libertà di informazione on-line. Sennonché, le conclusioni a cui perviene la citata sentenza non risultano convincenti laddove si impone ai motori di ricerca di deindicizzare (e cioè non considerare nell’ambito delle ricerche avviate dagli utenti) i contenuti considerati lesivi del diritto all’oblio degli interessati; ed infatti, non a caso, esse appaiono in contrasto con la giurisprudenza sul punto della Cassazione italiana e della CEDU. Il rischio maggiore di una tale soluzione, a prescindere dalla sua sostanziale inefficacia pratica dovuta al fatto che il principio vincola gli operatori solo all’interno dei confini europei, consiste nell’attribuire a soggetti privati – quali sono, per l’appunto, i provider che esercitano i motori di ricerca – il potere di decidere quali contenuti della Rete rendere rintracciabili agli utenti e quali invece sostanzialmente nascondere, o meglio nel legittimare, sul piano giuridico, l’esercizio, più o meno arbitrario, di un potere che, di fatto, detti provider hanno già. Sullo sfondo, e tutto intorno, la profonda crisi del diritto rispetto alle nuove tecnologie.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Quello che il diritto non dice. Internet e oblio. 2014.pdf
Solo gestori archivio
Descrizione: Saggio sul diritto all'oblio in Internet
Tipologia:
Versione dell'editore
Licenza:
DRM (Digital rights management) non definiti
Dimensione
1 MB
Formato
Adobe PDF
|
1 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.